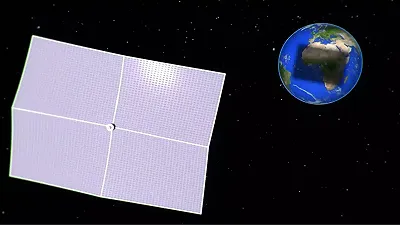Premiato a Cannes nell’anno 2015 Sole Alto si svolge nel paesaggio immutato di una provincia balcanica in tre annate diverse (1991, 2001 e 2011) eppure in un anno zero permanente dei dissapori inter etnici: l’amore è in prima linea a subirne e smaltirne gli effetti collaterali.
Tihana Lazović, Goran Marković, Nives Ivanković, Stipe Radoja, Trpimir Jurkić, Slavko Sobin sono le attrici e gli attori che, interpretando personaggi sempre diversi ma con lo stesso volto senza tempo, portano sullo schermo il fardello dei legami recisi, delle famiglie amputate, dei popoli spaccati in due e soprattutto dell’amore ostacolato alla Giulietta e Romeo. La ferita aperta, di triste portata storica e sociale, prima di spillare rabbia e dolore va a covare un Odi et amo catulliano (carme 85), in un silenzio inquieto che spesso è attesa della detonazione. Sotto quest’aspetto
la pellicola ha un carattere molto grunge
e per ognuno dei tre capitoli ne offre una o più prove lampanti. Nel primo, ad esempio, passiamo nel giro di pochi minuti da un clima meramente disteso a un headshot gratuito: prima un montaggio essenziale alterna l’allegra festicciola di paese al personaggio furibondo che tenta di raggiungerla guidando a tavoletta, poi gli eventi evolvono con gente che si butta da macchine in corsa o che le rincorre suonando la tromba, infine un ragazzo in una postazione improvvisata con vetture militari e nuove leve in panciolle (lungo un fantomatico confine) secca con un colpo di fucile la non-violenta sonata d’amor non appena prende le forme di un pogo a due.
L’episodio, partito come un fenomeno di bullismo, finisce in stile scarica di mitraglia sulla schiena di un tedesco della Germania Est che tenta di scavalcare. In altre occasioni meno drastiche un semplice pasto in compagnia, un dialogo che tentenna e persino un momento idilliaco sanno trasformarsi in concerti hard rock con tanto di urla sguaiate.

Alla base di tanto amore negato e inacidito nell’odio, oltre che una politica dettata dall’alto c’è quella inverata dal basso, fatta di (in)decisioni prese alla leggera, costrizioni più o meno auto indotte e bisogni primari quali il lavoro/studio e la rassegnazione/accettazione nei confronti dello stato paterno o del grande fratello del caso (che non guarda attraverso spioncini o cimici ma con gli occhi dei suoi sudditi e delatori).
È innegabile un tocco fantascientifico, dovuto non solo alle scelte di casting e sceneggiatura, nel presentare questo viaggio nell’arco di un ventennio.
Lo spettatore rimane disorientato almeno quanto i personaggi, incastrati in una dimensione dove pochi elementi testimoniano il cambiamento: se nel 1991 la musica esce dirompente da una tromba e da una banda di paese, e nel 2001 è segregata in un paio di cuffie – unico segno di una modernità che da qualche parte ha alzato il tiro – nel 2011 un festival di elettronica (momento di gran cinema che fa un baffo a Nicolas Winding Refn) dà una parvenza di ritorno inter comunitario.
In questo pianeta a parte, estatico quanto provinciale, è possibile ancorarsi all’unica certezza del bagno al lago, una volta questione di pigrizia, o anche proibito, e la volta dopo preferibile al sesso mentre l’alba avanza e il sole cresce: le scene sottomarine fanno stravincere l’esperienza visiva/emotiva e sono un luogo di salvezza, un battesimo laico per affrontare il futuro.

Si ha l’impressione, di fronte ad alcune riprese, che manciate di fotogrammi siano lasciate al caso, e fungano da volgare riempimento. La scommessa è sapersi ricredere, prestando attenzione alla coerenza interna e a come il regista nelle fasi 2001 e 2011 scelga di indugiare nei solchi tracciati dai decenni precedenti: una casa abbandonata, l’amore e la guerra; una casa ristrutturata, l’amore e la separazione fra etnie ancora vigente; l’odi et amo che sfuma, la porta di casa aperta e un ricongiungimento famigliare in vista.
In questo senso il corpo recitativo si passa di mano in mano una specie di torcia olimpica che rappresenta lo spirito e la storia comuni
e depone a favore di una fratellanza indebita, scambiandosi le colpe e poco a poco (decennio dopo decennio) relativizzando i pregiudizi e le sofferenze.
In ultima analisi unendo il fattore grunge a quello fantascientifico, strappati a forza da un contesto che di primo acchito non li sfiora neanche, troviamo una sorta di Big Bang a fare da scheletro al film: una fluttuazione spontanea, pari a un grilletto nevrotico premuto appena, rompe la quiete originaria (ma già febbrile) di un punto con volume tendente a zero e densità/temperature all’infinito – trattasi nel nostro caso di un innocuo amore appassionato.
Il lamento e lo strazio che ne derivano abbandonano l’unica lingua parlata, il serbo-croato, che da quell’istante comincerà a sdoppiarsi e a dividersi come del resto faranno le due rispettive galassie/nazioni. Entrando nel dettaglio dell’headshot iniziale, questa prima faglia simbolica, aperta nel cranio di una persona, successivamente agirà da specchio e ricordo indelebile di una guerra che non viene mai mostrata direttamente ma solo attraverso la desolazione umana, gli edifici distrutti e le lapidi dei giovani caduti.

Il finale, come anticipato, lascia aperta una porta di casa, e sull’uscio della riconciliazione un uomo si volta per seguire con lo sguardo la scia della donna appena entrata, forse con l’intenzione di raggiungerla, e determina un cliffhanger amaro che dovrebbe sapere di speranza: partono i titoli di coda.
Scritto e diretto da Dalibor Matanić, Sole Alto è stato distribuito in Italia da Tucker Film nel 2016.