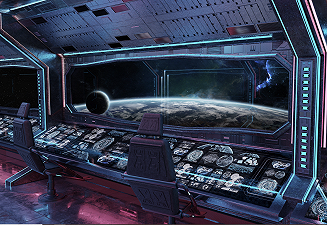Sapete, ho corso tantissimo da bambino. Mia nonna possedeva un casolare in campagna con un cortile immenso, ed io passavo tutte le domeniche pomeriggio a correre avanti e indietro con i miei cugini. Nonostante fossero più grandi di me, quando gareggiavamo arrivavo sempre primo.
A scuola eccellevo in educazione fisica e come potrete immaginare ero il più veloce del mio anno. Magro, snello, un fisico nervoso non ancora sviluppato. Alle medie il professore di ginnastica mi prese sotto la sua ala e mi convinse ad allenarmi seriamente per partecipare alle prime gare.
Al liceo la cosa cominciò a farsi più seria. Frequentavo le lezioni di mattina e studiavo alla sera. Il resto del tempo lo passavo ad allenarmi su una pista di atletica. Ero ancora magro, ma nel giro di un anno avevo preso quindici centimetri e il mio fisico aveva cominciato a farsi più slanciato.
Avevo anche cominciato a vincere. Prima a livello locale, poi regionale, finché alla fine del secondo anno mi ritrovai nella gara finale del campionato del mio stato. Arrivai secondo, battuto da un ragazzo due anni più grande di me. Ma vinsi l’anno dopo. E quello dopo ancora. Partecipai a competizioni internazionali, e anche lì ero al passo con i migliori.
Il liceo a quel punto stava finendo, ed io dovevo decidere cosa fare della mia vita. Mi trovavo a dover scegliere: mollare lo studio e dedicarmi anima e corpo alle competizioni oppure iscrivermi a Biologia. In quegli anni, infatti, furono resi legali gli esperimenti transgenetici volti alla creazione di nuove razze animali grazie alla fusione di DNA diversi fra loro, e anche se preferivo allenarmi quello era un campo che solleticava la mia curiosità.
In fondo è comico, perché se avessi scelto di correre come professionista oggi forse non sarei in questa situazione. Invece cedetti alle pressioni dei miei genitori e mi iscrissi all’università. Saltò fuori che ero molto portato per la materia. Fu un bel periodo a pensarci ora. Conobbi la madre dei miei figli, gli amici che frequento ancora oggi, e anche se meno di prima andai avanti a correre e a togliermi qualche soddisfazione in alcune piccole competizioni universitarie.
Mi laureai brillantemente e fui assunto come ricercatore dalla Transgenix. Oggi la conoscono tutti, è l’azienda che vende tutti quegli animali strani, fra cui i porcellini d’india volanti che tanto piacciono ai bambini. Ai tempi invece era solo una giovane start up intenta a cavalcare l’onda di un nuovo fenomeno.
I ritmi di lavoro erano forsennati. Passavo dodici ore al giorno chino su un computer a risequenziare DNA insieme a altri tre neolaureati. Il mercato aveva un grosso potenziale, ma nessuno aveva ancora ben capito come sfruttarlo. L’obiettivo del nostro team era di provare tutte le combinazioni che ci venivano in mente e creare qualcosa di commercializzabile.
Per sei mesi non riuscimmo a realizzare nulla di buono, e senza un prodotto da vendere l’azienda aveva cominciato a trovarsi in cattive acque. Gli investitori stavano perdendo la pazienza, e i proprietari venivano quasi ogni giorno a farci pressione affinché tirassimo fuori qualcosa di vendibile. Inoltre non riuscivo quasi mai a uscire dal laboratorio, dormivo lì anche quattro o cinque sere a settimana. Facevo quasi fatica a vedere mia moglie, figuratevi andare a correre. Non riuscendo più ad allenarmi avevo cominciato anche a prendere qualche chilo di troppo.
Però quel lavoro era appassionante. Se dall’esterno sembrava che fossimo quattro falliti intenti a inseguire una chimera noi sapevamo che stavamo creando qualcosa di assolutamente nuovo. Se solo avessimo voluto, avremmo potuto far nascere sul serio una chimera. Con il passare del tempo il giardino del laboratorio si popolò di strane bestie partorite dal connubio fra le nuove tecniche genetiche e la nostra fantasia. La prima fu il cangulemure, una simpatica scimmietta con le zampe da canguro riusciva a fare salti di sei metri da una pianta all’altra. Poi man mano ne vennero altri come il tartapony, un cavallino con una corazza sulla schiena, il caneleonte, un cane che cambiava colore secondo la situazione, o il brucoragno, un ragno che diventava crisalide e infine farfalla. Lavoravamo con molto buon senso, e tranne che nel caso del serpente volante nessuna delle creature che creammo si dimostrò poi aggressiva o pericolosa.
I pericoli semmai venivano dall’esterno. Un’agguerrita pattuglia di animalisti stazionava giorno e notte fuori dal nostro stabile tirandoci uova e altri oggetti ogni volta che cercavamo di uscire. La pressione era molto alta, e ogni progetto presentato ai piani alti della società era respinto perché troppo audace per essere presentato a un pubblico che per la maggior parte considerava ancora contro natura la transgenetica.
Fino a che non inventai il delfino nano. Non era niente di innovativo, solo un delfino del Rio delle Amazzoni delle dimensioni di un pesce rosso. Però era intelligente, si affezionava ai padroni, saltava fuori dall’acqua quando era felice e con un minimo di addestramento faceva tutto ciò che gli ordinavi di fare. Inoltre era il primo animale fra quelli che avevamo creato a suscitare più simpatia che curiosità, e per questo fu accettato dalla società. Nel giro di un paio d’anni in metà delle case del paese c’era una vasca contenente la mia creazione. L’azienda decollò, noi diventammo ricchissimi ed io fui promosso direttore creativo dei nuovi progetti.
In seguito furono messe sul mercato creature sempre più particolari. La gente imparò a convivere con questa novità, e dopo qualche anno persino il dipartimento della difesa cominciò a interessarsi alle nostre attività. Ci arrivarono diverse commesse da parte loro. Inizialmente domandarono solo degli insetti in grado di svolgere il lavoro di registrazione tipico delle cimici elettroniche usate dalle spie. In seguito le richieste diventarono più bizzarre. E più pericolose.
Un mattino si presentò al nostro stabilimento direttamente il segretario della difesa. Era un progetto top secret, ci disse, e non dovevamo lasciare trapelare nulla per nessuna ragione. In quei giorni si stava combattendo nella giungla dello Zaire una spietata guerriglia nella quale le milizie stavano avendo la meglio sulle forze dell’ONU sfruttando le caratteristiche del territorio. Il segretario ci chiese di sviluppare un animale feroce, agile e potente da diffondere della giungla equatoriale per rendere infernale la vita delle milizie africane.
Ci rendevamo conto che più che una richiesta quella del segretario fosse un ordine, e per quanto la cosa non ci piacesse non potevamo esimerci dal realizzare quel progetto. Così nacque la tigre corazzata. Una bestia di un’agilità eccezionale che non tradiva la tonnellata di stazza, con enormi zanne sempre pronte ad azzannare qualunque cosa le passasse sotto tiro per sfamare un’immensa fame. Dotato della furbizia di un felino accoppiata alla perspicacia di un grande primate, aveva dure placche di coccodrillo a protezione di cranio, ventre e schiena. La sua astuzia e la sua aggressività ci causarono non pochi problemi durante la fase di collaudo, che culminarono con l’uccisione di due miei collaboratori e la fuga di un piccolo branco.
La cosa per me fu intollerabile. Mi dimisi, ma il danno ormai era fatto. Avevamo programmato le tigri in modo da riprodursi in maniera frenetica, così nel giro di un anno tutta la regione ne era infestata. Ci volle quasi un lustro per riuscire a debellare la minaccia, e durante quel periodo le bestie compirono stragi efferate ogni volta che riuscirono a venire in contatto con l’uomo. Inoltre si vociferava che qualche esemplare solitario si aggirasse ancora per i campi e nelle periferie abbandonate, nascondendosi alla vista dell’uomo per evitare di essere predato.
Io ero sommerso dai sensi di colpa, sentivo che quell’enorme spargimento di sangue era stata solo responsabilità mia. Lasciai il settore, cominciai ad andare in analisi e accettai di buon grado una cattedra in un’università.
È passato tanto tempo da allora, ormai sono in pensione, ma i miei problemi con la tigre corazzata sembrano non essere ancora finiti. Stamattina ho deciso di tornare nel vecchio casolare di mia nonna. L’ho ereditata assieme ai miei cugini qualche anno fa ma fino ad oggi non abbiamo avuto il cuore né di tornarci né di venderla.
Ho portato anche un paio di scarpe da ginnastica per fare una corsa nel vasto prato in ricordo dei vecchi tempi. Ora sono in piedi all’inizio della radura, l’erba alta fino alle ginocchia, accarezzato dal sole primaverile in uno splendido pomeriggio di marzo. Sento un rumore dietro di me. Un brivido mi corre lungo il corpo, quel ruggito mi è un po’ troppo famigliare.
Mi giro, a venti metri di distanza un felino gigante mi guarda con uno sguardo truce. Non ha un bell’aspetto, deve essersi nascosta per anni nella vecchia casa. Comunque è dieci volte più grosso di me. E almeno il doppio più veloce. Sono spacciato, lo so.
Però ho ancora un’ultima scelta. Posso correre a perdifiato lungo il prato dove sono cresciuto, assaporando il fresco sapore del vento sul viso fino a che non mi raggiunge. Oppure posso finalmente lasciarmi andare, e usare i pochi respiri che mi rimangono per urlare un’ultima, enorme bestemmia.