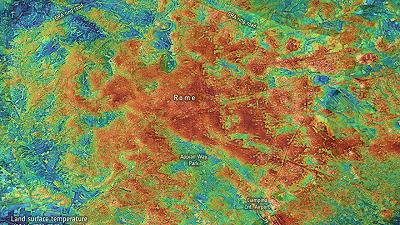Alle quindici in punto, si aprirono le porte. Tutte le porte. Il suono, basso e sordo, echeggiò per ognuna di esse. Da quelle automatiche delle boutique di Main Street fino alle saracinesche dei garage alla periferia nord; dalle porte in mogano lucido degli uffici del centro fino a quelle in vetro dei negozi di alimentari, incastrati fra le villette a schiera della zona residenziale sud
Gli altoparlanti si zittirono dopo cinque secondi, come ogni giorno, e la vita riprese a scorrere. Negli studi legali ai piani alti dei grattacieli le segretarie ricominciarono a passare telefonate, scrivere appunti, curare la contabilità. Schiere di uomini in completo e valigetta fecero la propria comparsa per le strade, marciando con precisione verso i rispettivi luoghi di lavoro. Le porte aperte li inghiottirono uno ad uno.
Le fabbriche della zona industriale nord tornarono a scandire il tempo con precisione metallica, riempiendo l’aria del proprio martellare ritmico. Le casse dei supermercati ricominciarono a tintinnare, sotto il tocco agile di mancate dita da pianisti. Per le strade, in una processione ininterrotta che non conosceva code o incidenti, si muovevano orde di autoveicoli, ognuno con il proprio preciso ed indispensabile compito.
Quell’insieme disparato di attività produceva una somma confusa di suoni, che salivano verso il cielo in una sola gigantesca cacofonia, qualcosa di paragonabile ad uno sciame di insetti disorganizzato. Questa, almeno, sarebbe stata la percezione che ne avrebbe avuto un estraneo appena arrivato nella Città – se la Città ne avesse ammessi. La verità era un’altra, sebbene nemmeno le orecchie degli abitanti potessero percepirla con chiarezza.
Solo alzandosi in volo a parecchi metri da terra un orecchio attento avrebbe notato come quell’apparente disarmonia sonora si ricongiungesse, in realtà, in una sintesi coerente ed armonica. Da quell’altezza un occhio ugualmente attento avrebbe notato che anche lo scorrere degli autoveicoli possedeva una regolarità, una precisione intrinseca. Se quello stesso occhio avesse potuto isolare ogni singolo movimento che avveniva lì sotto, negli spazi sterminati della metropoli, avrebbe finito per realizzare che persino quelli – dai gesti svolazzanti dei commessi a quelli rigidi e precisi degli operai – erano tutt’altro che casuali. Ogni movimento era collegato ad un altro, tutti quanti uniti a formare un’unica gigantesca macchina razionale.
La Città era viva. Il suo sangue era un flusso di carne e metallo, scorreva fluido ed ininterrotto per le vene di cemento che la attraversavano. La sua voce raccontava una storia sola, quella di un moto infinito e infallibile. Il suo pensiero, perennemente vigile, non faceva che contemplare sé stesso e la propria immota perfezione. E i suoi abitanti non conoscevano né dolore, né infelicità, né Morte.
Quel giorno, in cima al grattacielo più alto della metropoli, stava un Uomo. Era stato, come tutti gli uomini, un figlio della Città; almeno fino al giorno in cui non aveva incontrato Lei.
Una notte uguale a qualunque altra l’uomo si era addormentato, e aveva iniziato a sognare. Gli abitanti della Città non sognavano altro che la Città, perciò era stato per lui molto strano ritrovarsi a fissare il volto sconosciuto di una donna che – ne era certo – non apparteneva alla Città. Nel sogno l’uomo si era guardato intorno: gli sembrava di essere per le strade della Città, seppur mai nello stesso punto, come se lo spazio che lo circondava mutasse continuamente, senza permettergli di metterlo a fuoco. Solo Lei era perfettamente distinguibile. Lo aveva chiamato per nome, e gli aveva parlato: il sogno era durato tutta la notte, la prima di tre notti consecutive in cui Lei gli aveva fatto visita, istruendolo. Nei sogni lui si limitava ad ascoltare i suoi insegnamenti, assimilandoli senza comprenderli del tutto. Ad ogni risveglio tentava di richiamare alla memoria i dettagli di Lei: la forma del viso, gli occhi, il colore dei capelli, gli abiti che indossava. Tutto inutile. Di lei avrebbe ricordato solo tre cose: le sue parole, il suo sorriso, e il suo nome.
« Cosa dovrò fare con quel che mi hai insegnato? » aveva chiesto alla fine del terzo sogno, conscio del fatto che sarebbe stato l’ultimo.
« Tienilo segreto, nel ricordo, e fa in modo che nessuno sappia di me o di quel che hai imparato. Poi, quando lo riterrai giusto, mettilo in pratica. »
« Non capisco. »
Lei lo aveva guardato per lunghi attimi, quindi aveva sorriso. E lui, vedendo quel sorriso, aveva pensato che in esso c’erano il fuoco, il sangue, il sole. Era rosso, caldo, luminoso, e violento e bello e spaventoso. Parole che fino a quel momento erano state solo parole avevano iniziato a concatenarsi nella sua mente l’una all’altra, in una sincronia di significati. E da quelle parole ne erano nate di nuove, sconosciute fino a quel momento e che tuttavia l’uomo comprendeva perfettamente, quasi riaffiorassero alla superficie della sua coscienza dopo essere state dimenticate da tempo. Stupore, felicità, desiderio. Ma anche paura, odio, rabbia. Parole che gli riempirono la testa, parole che nella Città – ne era certo – non avrebbe compreso nessun altro.
Perché sebbene gli abitanti della Città non conoscessero la Morte, il dolore o l’infelicità, nemmeno conoscevano la gioia, il piacere o i colori. Nella Città non c’era spazio per altra musica che quella metallica delle fabbriche, per altro colore che il grigio uniforme del cemento. I cuori degli abitanti erano vuoti, ciechi e sordi al canto di quell’anima che avevano sacrificato sull’altare della perfezione. I loro corpi vivevano l’esistenza eterna che è propria delle statue, priva di alcun senso al di fuori di sé stessa.
Alla fine del terzo sogno l’uomo si era svegliato, unico vero Uomo in tutta la Città, e aveva capito.
Per questo motivo quel particolare giorno l’Uomo si trovava in cima al grattacielo più alto della Città, fissandola con gli occhi nuovi che Lei gli aveva regalato. Erano passati tre giorni da quando aveva deciso di agire: in ognuno di essi aveva messo in pratica una parte di ciò che lei gli aveva insegnato, preparandosi per quel momento.
Durante la prima notte la Donna gli aveva parlato della forme e dell’importanza che esse avevano. La Città era il cerchio, e i suoi abitanti ne percorrevano il perimetro in un moto continuo. La prima cosa che avrebbe dovuto fare sarebbe stata spezzarlo: così, il primo giorno aveva percorso i confini della Città a piedi, tracciando con il pensiero una linea che si ricongiungesse a sé stessa. E dopo averlo fatto, nel punto in cui il cerchio si era chiuso, aveva versato tre gocce del proprio sangue, pronunciando le parole che lei gli aveva detto. La seconda notte la donna gli aveva dato un nuovo nome, a cui l’Uomo si sarebbe dovuto consacrare con un giorno intero di digiuno e meditazione: così lui aveva fatto il secondo giorno, restando in casa, al buio, la mente persa nel pensiero di quel nuovo sé che avrebbe compiuto l’opera. Nel terzo ed ultimo sogno gli erano state rivelate le parole del potere, come e dove usarla, e infine il nome di colei che lo aveva scelto per quel compito.
Il terzo giorno era giunto, e lui era pronto a compiere l’ultimo passo. Mentre fissava di fronte a sé qualcosa gli strinse la bocca dello stomaco: era la prima volta che sperimentava quella sensazione, sebbene sapesse dargli un nome. Paura. La ignorò, muovendosi verso il bordo del cornicione. In due passi scavalcò il parapetto e si ritrovò a fissare la strada, cinquanta piani più sotto, brulicante di uomini e macchine. Passarono alcuni attimi, quindi l’uomo alzò lo sguardo ed iniziò a cantilenare. La sua voce si levò chiara e forte, salendo al cielo insieme ai suoni della metropoli e spezzandone con violenza l’armonia.
Ad ognuna delle dodici sillabe pronunciate dall’uomo la Città tremò: il moto del traffico accelerò, poi rallentò, scosso da qualcosa di ignoto. Due auto si tamponarono all’incrocio fra la quarta e la settima strada; una donna, seduta su una panchina di Central Park, incominciò a ridere senza alcun motivo – a ridere davvero, di gusto, come mai non ricordava di aver fatto in tutta la sua vita. Lontana, oltre la linea dei palazzi, qualcosa di simile ad una gigantesca ombra tridimensionale si alzò sulla Città.
Dopo alcuni secondi di silenzio l’uomo mosse un passo in avanti, oltre il bordo del cornicione, pronunciando le ultime due sillabe che racchiudevano il nome di Lei. Quindi precipitò nel vuoto.
Lenta e silenziosa, l’ombra si abbatté sui palazzi e sulle case come un’onda anomala, sebbene agli abitanti apparisse come un’increspatura nell’aria. Portava con sé i colori, e gli occhi necessari a vederli. Quando l’onda ebbe terminato la propria caduta, ogni cosa nella Città si fermò. Il silenzio riempì l’aria per lunghi interminabili minuti, mentre gli abitanti sperimentavano qualcosa a cui sapevano di dover dare il nome di stupore. Poi, una ad una, le loro voci tornarono ad udirsi: erano urla di gioia, di paura, erano sospiri di estasi e mormorii di comprensione. Erano mille voci diverse che iniziavano a raccontare ciascuna la propria storia, librandosi in una confusione multicolore sopra una nuova città: imperfetta, caotica, vera.
Durante la caduta l’uomo non urlò; non si accorse nemmeno dello schianto. Semplicemente, dopo l’ultimo passo e la sensazione spaventosa del vuoto sotto i piedi, perse cognizione di sé. Quando la ritrovò scoprì di essere da qualche parte nel cielo sopra la metropoli. Sotto di lui le strade splendevano di una nuova luce. Accanto gli stava una donna, e il suo sorriso era rosso come il sole. La conosceva bene, ormai. E sapeva che ben presto, come era giusto che fosse, la avrebbero conosciuta anche gli abitanti della città: insieme alla gioia e al dolore, ai colori e alla musica. Senza mai sperimentarla davvero, ma sapendo che Morte era il nome che le era dovuto – insieme al privilegio, a lei sola, dell’eternità.